il tuo sito di informazione musicale
![]()
FEU ROBERTSON "The underground secession"
(2019 )
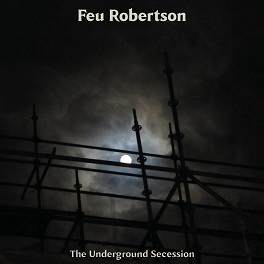 I Feu Robertson li voglio immaginare così: interno notte, nel retro di un qualche locale della periferia di Reims. Su un divano di pelle mezzo sfondato, parzialmente celati dietro una cortina di fumo, vagamente alticci, rilassati a suon di birra dopo uno show, o magari durante una serata qualsiasi.
I Feu Robertson li voglio immaginare così: interno notte, nel retro di un qualche locale della periferia di Reims. Su un divano di pelle mezzo sfondato, parzialmente celati dietro una cortina di fumo, vagamente alticci, rilassati a suon di birra dopo uno show, o magari durante una serata qualsiasi.
Oppure: esterno notte, spiaggia-di-chissà-dove, chitarra e bonghi. Parzialmente celati dietro una cortina di fumo, vagamente alticci, rilassati a suon di birra dopo uno show, o magari durante una serata qualsiasi.
Ma di sicuro mi sbaglio, e i Feu Robertson sono gente che suona in parrocchia raccogliendo offerte per ristrutturare il battistero, o nei circoli culturali, o nei centri sociali, o nei chiostri di qualche complesso monumentale onusto di storia&gloria.
Con questi quattro tizi francesi – tre signori ed una signora - di certezze ce ne sono ben poche. A partire dai nomi di battesimo, che nelle note di copertina e nelle cartelle stampa hanno stavolta cambiato in una goliardica boutade.
Quarto album dal 2014, “The underground secession” esce per Partycul System a breve distanza da “Tremblez tyrans”. Finiscono su queste pagine per la terza volta in quattro anni, e l’effetto è sempre lo stesso: spiazzante. Musica ondivaga, free-form, non inquadrabile, sebbene riferibile a qualcosa. Psichedelia d’antan, Beatles, folk acido à la Roky Erickson, Floyd post-Barrett, Barrett solista (sic!), polvere da vecchi scaffali, un sentore di tempi andati, qualcosa di inafferrabile che descrivervi non saprei. Incomprensibili, affascinanti. Un incessante movimento, calderone il cui principale ingrediente è un mood crepuscolare e lunatico fatto di melodie cangianti, percussioni mai accentuate, armonie dilatate, aperte, sornione e spiritate.
Negli emblematici sette minuti di “Smoking kills” va in scena tutto il repertorio di arte varia di questa indefinibile compagine sghemba: arpeggi, echi, riverberi, oasi di stasi e clamorosa quiete, catene di accordi che vanno e vengono come vecchi bonzi ubriachi, slabbrati cori da falò, voci doppiate in falsetto, singalong improbabili. Intuizioni che paiono lievitare, e invece precipitano. “Smoking kills” – così per dire - a due minuti dalla fine si infila in un cul de sac infernale su un tempo dispari sventrato da ogni possibile disturbo.
“Soft summer I” si sviluppa su un’aria cajun attorno ad un giro di banjo in minore sublimato da una sbracata coralità: come se i Jayhawks in acido cantassero un pezzo degli Arcade Fire. E poi tracce strumentali, intermezzi, svolazzi casuali, perfino il surf truccato di una “Soft summer II” che pare una via di mezzo tra i Broncho e Beck, con tanto di ritornellone sguaiato. “Harmonica montana” è un rallentamento catatonico muto che nasce dal nulla e nel nulla collassa, apparentemente senza un senso preciso; “Long board surf” è proto-garage post-Television o pre-Strokes; “Hawaiian crossroad” muta un esordio serafico in una ballata da Pixies.
In coda, i sette minuti e passa di “Loose lips” originano – come tutto il resto ha fatto già – da una cantilena balorda su una cadenza simil-blues, per deviare ben presto verso una contagiosa armonia dettata dal ritornello (?), dal bridge (?), dalla strofa (?). Ma quale parte della canzone è cosa, in fondo? Poco conta: nei tre minuti finali tutto va alla deriva in una nenia circolare infinita, che potrebbe essere farina del sacco dei DIIV, una coda dei Red House Painters o una jam drogata che nessuno vuole interrompere.
Questo accade con ogni album dei Feu Robertson: è un gorgo che ti inghiotte, ma dal quale non tenti di liberarti. Non saprei come altro definirlo. (Manuel Maverna)