il tuo sito di informazione musicale
![]()
MATT CHRISTENSEN "Honeymoons"
(2017 )
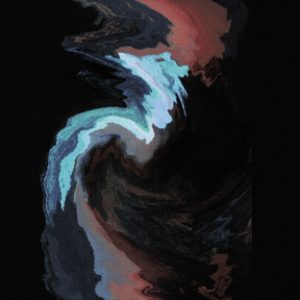 In certa misura autoesiliatosi in una turris eburnea dalla cui sommità pontifica per pochi eletti, noncurante della complessità della musica offerta, Matt Christensen da oltre vent’anni sussurra il proprio verbo impalpabile e rarefatto attraverso le varie incarnazioni di cui è stato protagonista. Messosi in luce dapprima con i Zelienople, trio di Chicago formato con Brian Harding e Mike Weis, in seguito come performer al fianco di nomi quali Jaime Fennelly (Mind Over Mirrors) e John Twells (Xela), Matt opera da un lustro come solista, affidandosi essenzialmente ad un connubio di chitarra e voce mediato da un’effettistica atmosferica composita e stratificata.
Da qualche parte al crocevia tra ambient, pop music elitaria, elettronica non invasiva e sperimentazione concettuale, Matt disegna un’eterea successione di suoni free-form che rinunciano ad una struttura rigida per concedersi di vagare in un flusso ininterrotto di raffinata eleganza ed inafferrabile purezza. La sua voce risuona al contempo inespressiva ed evocativa, emergendo inquieta e profonda tra molteplici ascendenze ed infiniti ipotizzabili rimandi, ogni frammento del puzzle potendo appartenere a mondi e galassie indifferentemente lontanissimi o limitrofi, rompicapo che vaga senza soluzione verso lidi irraggiungibili.
Emblematici i nove minuti di “Sometimes”, che celano sia un blues trasfigurato disumanizzato dai sample crepuscolari mandati in loop, vicino alla stasi trascendente dei For Carnation di Brian McMahan, sia paradossalmente ai soliloqui più intimi di Marc Almond. Il passo languido di queste tracce che trasudano una dimessa desolazione mentre convogliano l’emotività verso direzioni mai univoche, riporta sovente all’aura di ineffabilità che rese memorabili – ed inarrivabili – almeno due capolavori di Mark Hollis e dei suoi Talk Talk (“Spirit of Eden” e “Laughing stock”) così come l’altrettanto preziosa filigrana che descriveva le trame del seminale “Hex” dei Bark Psychosis.
A tratti pare di sfiorare addirittura le tessiture art-rock dei Flying Saucer Attack private del feedback che le sommergeva, ma si tratta soltanto di miraggi, illusioni, suggestioni sparse come indizi frammentari: si muove sinuosa “I’m see through”, bipartita fra echi ambient ed inserti al limite del glitch, procede esitante la strumentale “Los Angeles” su un tappeto ipnotico che pesca da Fripp come da Sylvian, chiude “Let me in” su un cantilenare ammaliante degno dei Desertshore di Phil Carney, stasi e tensione a braccetto in un’opera la cui sottile impenetrabilità è la fonte stessa del fascino che la riveste. (Manuel Maverna)
In certa misura autoesiliatosi in una turris eburnea dalla cui sommità pontifica per pochi eletti, noncurante della complessità della musica offerta, Matt Christensen da oltre vent’anni sussurra il proprio verbo impalpabile e rarefatto attraverso le varie incarnazioni di cui è stato protagonista. Messosi in luce dapprima con i Zelienople, trio di Chicago formato con Brian Harding e Mike Weis, in seguito come performer al fianco di nomi quali Jaime Fennelly (Mind Over Mirrors) e John Twells (Xela), Matt opera da un lustro come solista, affidandosi essenzialmente ad un connubio di chitarra e voce mediato da un’effettistica atmosferica composita e stratificata.
Da qualche parte al crocevia tra ambient, pop music elitaria, elettronica non invasiva e sperimentazione concettuale, Matt disegna un’eterea successione di suoni free-form che rinunciano ad una struttura rigida per concedersi di vagare in un flusso ininterrotto di raffinata eleganza ed inafferrabile purezza. La sua voce risuona al contempo inespressiva ed evocativa, emergendo inquieta e profonda tra molteplici ascendenze ed infiniti ipotizzabili rimandi, ogni frammento del puzzle potendo appartenere a mondi e galassie indifferentemente lontanissimi o limitrofi, rompicapo che vaga senza soluzione verso lidi irraggiungibili.
Emblematici i nove minuti di “Sometimes”, che celano sia un blues trasfigurato disumanizzato dai sample crepuscolari mandati in loop, vicino alla stasi trascendente dei For Carnation di Brian McMahan, sia paradossalmente ai soliloqui più intimi di Marc Almond. Il passo languido di queste tracce che trasudano una dimessa desolazione mentre convogliano l’emotività verso direzioni mai univoche, riporta sovente all’aura di ineffabilità che rese memorabili – ed inarrivabili – almeno due capolavori di Mark Hollis e dei suoi Talk Talk (“Spirit of Eden” e “Laughing stock”) così come l’altrettanto preziosa filigrana che descriveva le trame del seminale “Hex” dei Bark Psychosis.
A tratti pare di sfiorare addirittura le tessiture art-rock dei Flying Saucer Attack private del feedback che le sommergeva, ma si tratta soltanto di miraggi, illusioni, suggestioni sparse come indizi frammentari: si muove sinuosa “I’m see through”, bipartita fra echi ambient ed inserti al limite del glitch, procede esitante la strumentale “Los Angeles” su un tappeto ipnotico che pesca da Fripp come da Sylvian, chiude “Let me in” su un cantilenare ammaliante degno dei Desertshore di Phil Carney, stasi e tensione a braccetto in un’opera la cui sottile impenetrabilità è la fonte stessa del fascino che la riveste. (Manuel Maverna)