il tuo sito di informazione musicale
![]()
BÄRLIN "State of fear"
(2023 )
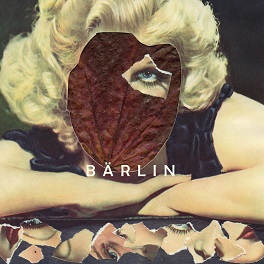 Ci sono dischi incatalogabili, opere inafferrabili che sfuggono a qualsiasi classificazione. Stanno rinchiuse in qualche scrigno segreto, nascoste alla vista, celate dai travestimenti che esse stesse hanno scelto come protezione. Dalla sedicente normalità, dal comune sentire, dalle strade più battute, dalla prevedibilità.
Ci sono dischi incatalogabili, opere inafferrabili che sfuggono a qualsiasi classificazione. Stanno rinchiuse in qualche scrigno segreto, nascoste alla vista, celate dai travestimenti che esse stesse hanno scelto come protezione. Dalla sedicente normalità, dal comune sentire, dalle strade più battute, dalla prevedibilità.
Formati da Clément Barbier, Laurent Macaigne e Simon Thomy, i Bärlin sono un trio francese originario di Lilla, nato all’inizio degli anni ’10 ed oggi giunto al quarto album di una carriera tanto defilata quanto incrollabilmente fedele alla linea. Statuaria, addirittura; impavida e spavalda, incurante di regole, mode, tendenze.
Refrattari a qualsiasi classificazione di comodo, si ripresentano con “State of fear”, su etichetta Lilian Prod, a tre anni dalle morbide contorsioni di “The dust of our dreams”; nella consueta anomala line-up (voce/clarinetto, basso, batteria) propongono nove tracce buie ed opprimenti, qualcosa al crocevia tra il David Sylvian del periodo “Gone to earth” (“Farewell song”), certe belluine suggestioni waitsiane, sublimate ad esempio nella congesta title-track, ed i Morphine dei primi tre album. Rispetto al taglio generale di Sandman & soci, riferimento d’obbligo, i brani suonano tuttavia più lugubri e sinistri, ammantati da un’aura di malsana tensione spesso sul punto di deflagrare, ma trattenuta, rimandata, compressa.
E’ un’escalation continuamente promessa e rinviata, condensata in canzoni dall’anima notturna, calate in un rimbombare di bassi profondi e assecondata dalle ondivaghe divagazioni del clarinetto; il canto è mutevole, insinuante, oscillante tra piglio attoriale e timbro stentoreo (“Deer fight”), o perfino incline ad un espressionismo stravolto, quasi maniacale (“Revenge”). Gli appigli mancano, le certezze si diradano, il battito insiste, il clima si appesantisce. Nessuna concessione o apertura fanno breccia in questo teatro sonoro che mischia art-rock e post-qualcosa, piccole escursioni in territori jazz (“All work and no play”), digressioni tenebrose, pulsioni avant (“Sgink Era Ew”).
Sempre elegante, discretamente teatrale (“Body memory”), mai violento né morboso, predilige un approccio obliquo; non è triste, non è aggressivo, non è soffocante né disperato, eppure conserva intatta un’atmosfera caliginosa, incombente, intrisa di pathos, fosca e plumbea. Gli otto minuti di “Sturm” in chiusura – con testo in tedesco, archi straziati e derive free - sono il degno epilogo di un album complesso e affascinante, lavoro di rara intensità che sfugge ad ogni definizione. (Manuel Maverna)