
LEONARD COHEN "Songs of love and hate"
(1971 )
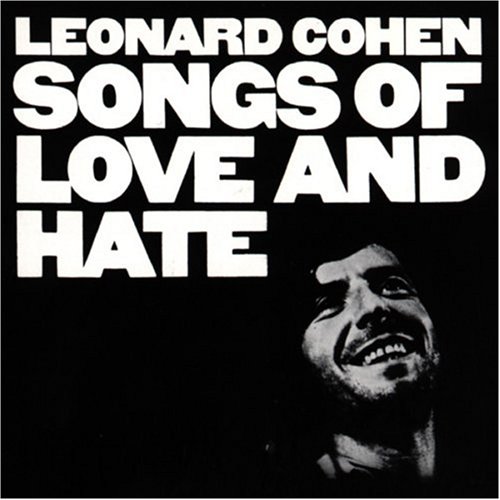 Stanare i fantasmi dalla mente umana, costringerli a lasciare i loro nascondigli più oscuri per uscire allo scoperto, in modo da poterli fissare in ritratti musicali minuziosi, spietatamente realistici, senza accarezzare le gobbe, senza tralasciare i particolari più orribili. Anche questa è un’arte, e tutt’altro che facile, a cominciare proprio dalla tecnica da usare.
Stanare i fantasmi dalla mente umana, costringerli a lasciare i loro nascondigli più oscuri per uscire allo scoperto, in modo da poterli fissare in ritratti musicali minuziosi, spietatamente realistici, senza accarezzare le gobbe, senza tralasciare i particolari più orribili. Anche questa è un’arte, e tutt’altro che facile, a cominciare proprio dalla tecnica da usare.
C’è chi pensa che per sondare il lato perverso del nostro animo basti un pittoresco kit di simboli diabolici (cadaveri più o meno decomposti, croci più o meno celtiche, 666 e altre amenità), il tutto accompagnato dal fracasso di chitarre distorte, urli bestiali e batterie impazzite. Non credo sia la strada giusta, e del resto Oscar Wilde nel suo spassoso racconto “Il fantasma di Canterville” ci ha insegnato che gli spiriti odiano il rumore e lo fuggono. E’ più probabile che ad attirarli sia il suono di una voce cavernosa, dolcemente stanca e disillusa, insieme a quello di una chitarra che accompagna con scarni, mesti accordi da campana a morto.
Ma anche questo non basta. Manca ancora la condizione più importante: che questa voce appartenga ad un poeta. Leonard Cohen lo è, sia nel senso letterale (o letterario), sia come autore di testi tra i più espressivi e profondi che siano mai stati musicati. E il suo terzo album, “Songs Of Love And Hate” (1971) non fa eccezione, anzi si può dire che rappresenti il fondo del suo tormentato scavo psicologico, il luogo più pericolosamente vicino al punto di non ritorno della disperazione totale.
L’album “nero” del grande poeta canadese è una galleria sconcertante di situazioni umane degradate, tanto che perfino l’unica eroina presente, Giovanna D’Arco (“Joan Of Arc”) lo è solo di nome. In realtà è una donna ormai rassegnata, stanca della guerra e vittima del ruolo fin qui avuto, stanca perfino della vita, che in un ultimo impeto di vitalità si concede al fuoco con la stessa passione con cui darebbe ad un amante.
Siamo lontani da quella tragedia dei sensi che travolge la “Nancy” del disco precedente, e ancora di più da quei colori vivi e indelebili che rendono affascinante la figura dell’ipersensibile “Suzanne” del disco di esordio. In ogni caso anche “Joan Of Arc”, come già le altre due icone femminili coheniane, colpì Fabrizio De André, che la seppe tradurre da par suo.
Leonard Cohen sa trarre il massimo dalla sua strumentazione essenziale. Prendiamo l’inizio di “Avalanche” (“Valanga”): le corde della chitarra, pizzicate nervosamente, vibrano come i cavi elettrici di una ferrovia prima che arrivi il treno. Si crea un clima di fremente attesa, accentuata dal grave lamento degli archi, e finalmente più che soddisfatta dall’autentica valanga di confessioni e rimorsi che la dura voce di Cohen scarica sull’ascoltatore indifeso, fino ai versi finali, micidiali nel loro totale rifiuto di ogni commiserazione: “Non vestirti di stracci per me, so che non sei povero; e non amarmi tanto ferocemente, quando sai di non essere sicuro…”. Roba da turbare la sensibilità di un economista.
Lo stesso pizzicato frenetico anima “Love Calls You By Your Name”, ma qui almeno il testo offre un qualche appiglio, proprio grazie al verso che fa da titolo (“L’amore ti chiama per nome”), un pallido ma inaspettato raggio di sole che chiude ogni strofa. Non è un caso che simili tremiti di chitarra faranno da sfondo prima al testo-confessione più toccante mai scritto da Fabrizio De André (“Amico fragile”), e molto più tardi al suo più apocalittico quadro del mondo attuale (“La domenica delle salme”).
Ma ancora non abbiamo toccato l’abisso dell’infelicità. “Last Year’s Man” e “Dress Rehearsal Rag”, impietosamente poste in sequenza, ci riescono più volte. La prima è un’allucinante sequenza di immagini di sfacelo materiale e umano: “l’uomo dell’anno passato” vive in un luogo che è il simbolo stesso del suo degrado (“Il lucernario è come pelle di un tamburo che mai rattopperò”), e da qui ripassa lucidamente le tappe della sua rovina, senza muovere un dito per evitarla. All’inizio voce e chitarra ristagnano nella melma di lunghe note lamentose, poi la ballata si anima appena di quel tanto che basta per trascinarsi avanti in qualche modo.
In “Dress Rehearsal Rag” la disperazione è ancora più pressante: la voce di Cohen sembra opporre all’infinita tristezza della musica una certa rabbia, ma con un’intonazione da brividi, che fa temere da un momento all’altro lo scoppio di un pianto inconsolabile. Come se non bastasse alla fine di ogni strofa c’è da fare i conti con la domanda retorica: “E’ o non è stato un lungo declino, uno strano declino?” mentre alla fine ci si scontra con l’agghiacciante verità che in fondo tutto questo declino non è altro che “una prova generale in stracci” di qualcos’altro, che inevitabilmente verrà… (“Allegria!”, direbbe Mike Bongiorno).
Ci si riprende (relativamente) con “Diamonds In The Mine”, ibrido pre-waitsiano di reggae stravolto e cori spiritual, e “Sing Another Song, Boys”, immersa in un analogo clima di festa ubriaca e sgangherata, l’unica allegria che Cohen è capace di offrirci. Ma la “canzone d’amore e d’odio” per eccellenza è “Famous Blue Raincoat”. L’immensa tenerezza del suo bellissimo tema cantabile riesce a squarciare per un po’ il velo nero e lugubre che copre gran parte del disco.
Sotto il “famoso impermeabile blu”, naturalmente “lacerato alla spalla”, si nasconde un amico-nemico, traditore e tradito, al quale Leonard Cohen, in una insonne notte di dicembre, scrive forse la lettera più sincera e appassionata che sia mai stata messa in musica. I due amici-nemici hanno alle spalle e in comune un intenso rapporto con la stessa donna, ma almeno Leonard è così sopraffatto dal peso di quei lontani ricordi da non sapere se l’ex amico (“fratello mio, assassino”) gli manca, da non essere in grado di perdonarlo né di punirlo, ma soltanto di dirgli “se un giorno passerai da queste parti, per Jane o per me, voglio che tu sappia che il tuo nemico dorme; voglio che tu sappia che la sua donna è libera”, con lo stesso tono con cui traccia lo sfondo neutro della vicenda, una New York fredda ma piena di musica fino a notte inoltrata.
Che dire ancora? Che gli unici a cui si può sconsigliare un capolavoro del genere, per ovvi motivi, sono i depressi. Per il resto solo un caldo invito a leggere i testi: con Leonard Cohen ne vale sempre la pena. (Luca "Grasshopper" Lapini)