
PARTINICO ROSE "Songs for sad and angry people"
(2020 )
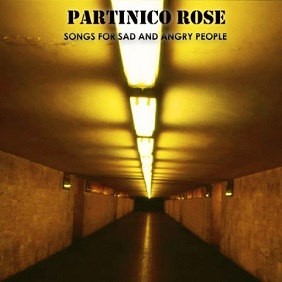 Dopo un paio di tracce, ero pronto a scommettere che quella che stavo ascoltando fosse una produzione della Seahorse Recordings di Paolo Messere: suoni pieni, oscuri, un mood al contempo incupito e melanconico. Programmatico e schierato fin dal titolo, “Songs for sad and angry people” è invece un’autoproduzione ben calibrata e sontuosamente realizzata, caratterizzata da un sound rifinito e squadrato di matrice dark-wave d’antan, figlia più di Cure e Killing Joke che dei nipotini Interpol.
Dopo un paio di tracce, ero pronto a scommettere che quella che stavo ascoltando fosse una produzione della Seahorse Recordings di Paolo Messere: suoni pieni, oscuri, un mood al contempo incupito e melanconico. Programmatico e schierato fin dal titolo, “Songs for sad and angry people” è invece un’autoproduzione ben calibrata e sontuosamente realizzata, caratterizzata da un sound rifinito e squadrato di matrice dark-wave d’antan, figlia più di Cure e Killing Joke che dei nipotini Interpol.
Trentasette minuti compatti e contriti attraversati da un senso di tensione strisciante segnano l’esordio del trio ragusano Partinico Rose: dieci brani mesti ed aggressivi arroccati intorno a pochi giri ripetuti ossessivamente secondo una concezione che richiama in parte le strutture dei Sisters of Mercy, talvolta trattenuti e diluiti in forma di ballate sofferenti (“The end of summer”, “Don’t leave me alone”), altrove deflagranti in violente impennate (“Misanthropy”) o ingorghi elettrici nervosi e spasmodici (“Mistakes in my head”).
In apertura, l’abbrivio percussivo che Carlo Schembari imprime a “Slave of time” sembra riemergere direttamente dall’abisso di “Pornography”, mentre il canto profondo e dolente di Vincenzo Cannizzo asseconda con piglio drammatico questa musica incalzante e tetra, nella quale l’elemento ritmico resta ovunque predominante insieme al pulsare martellante del basso.
E se alla fine del giro introduttivo di “I am looking for a job” ti aspetti che su quel rallentamento dilatato entrino il timbro strozzato e gutturale di Robert Smith o perfino la disperazione urlata di Jordan Dryer, “The revenge” non sfigurerebbe nel canzoniere di Brian Molko come la torch song sui generis di “Rehab from you”, impreziosita dal toccante violoncello di Martina Monaca, in quello degli Arcade Fire.
Fino alla straziante chiusura di “Could you share my pain”, il pathos costruito con accorata scrittura ed evidente partecipazione emotiva (mirabile “The story of cancer”) conserva intatta ed incombente un’aura ombrosa, ideale per esaltare l’aspra desolazione di un album tenebroso dall’incedere metronomico e circolare.
Figlio sì del post-punk e per nulla imparentato con le deviazioni più fosche di certo alt-folk, ma continuo a rimanere dell’idea che a Paolo Messere piacerebbe. (Manuel Maverna)